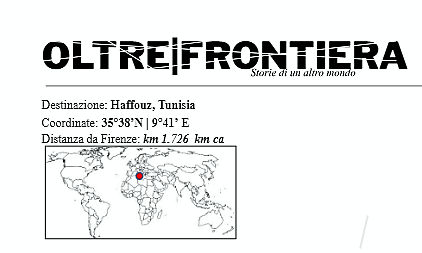
Nonostante tutti i nostri sforzi, e con noi intendo chiunque viva nella parte non disperata del mondo, non riusciremo mai a capire, fino in fondo, come si possa arrivare a fare quello che ha fatto Nizar Issaoui, il 10 aprile 2023, ad Haffouz, una cittadina nel governatorato di Kairouan, nella Tunisia centro settentrionale. Non ci sono analisi socio-politiche, né teorie comportamentali, né nuove concettualizzazioni che tengano. Il suo gesto è all’estremo opposto di tutto quello che riteniamo accettabile o sopportabile: Nizar si è dato fuoco. La sua agonia è durata tre giorni; la sua notorietà, qualcuno in più. Ma non poi così tanti. Perché darsi fuoco, qui in Tunisia, è una cosa relativamente normale. E non c’entra niente il fondamentalismo islamico. Non c’entra niente, per una volta, l’endemico risentimento africano verso l’occidente colonialista. La gente si dà fuoco per essere ascoltata. Il primo a farlo è stato un venditore ambulante. Si è dato fuoco per far sentire la sua voce. Ma in quel in quel preciso momento storico, in quel particolare contesto geopolitico, le sue urla strazianti l’hanno amplificata, invece di soffocarla, ed è diventata la voce di tutto un paese, sfinito da decenni di dittatura. I social network, poi, hanno fatto il resto. La sua immolazione ha acceso la scintilla della rivolta popolare che spodestò Zine el Abidine Ber Alì, proiettando il paese nell’elitario consesso dei paesi democratici. Dal 2010, la data dell’avvenimento – il 17 dicembre – è la nuova festa nazionale tunisina, e Mohammed Bouazizi, il venditore ambulante, è diventato un eroe nazionale. Da allora, questo orribile modo di togliersi la vita, ha una valenza politico sociale che nessuno osa mettere in discussione. Sono centinaia e centinaia gli emuli di Bouazizi; il loro numero è così elevato che dal 2016 la Tunisia ha smesso di pubblicare statistiche al riguardo, nel tentativo di far cadere l’interesse sul fenomeno. Ma, sebbene non più numerosi come i primi anni, i suicidi per immolazione ignea – tentati e riusciti – sono ancora uno o due a settimana.
Nella cultura tunisina, darsi fuoco è un atto di purezza. Non si tratta di semplice suicidio, né di un gesto folle, né tantomeno un segno di resa, di fallimento. La gente lo considera come un’espressione di verità. E di disperazione. Non è un caso che si usi la stessa parola – “harka”, che vuol dire, appunto, bruciare – per descrivere la traversata del Mediterraneo su barche di fortuna, o la trasformazione del proprio corpo in una torcia. È come dire che la Tunisia ti brucia sempre, sia che tu rimanga, sia che tu decida di scappare. È opinione diffusa che oggi, in Tunisia, esso sia l’unico modo per far sentire la propria voce.
Lo Stato è pervaso dalla corruzione, la democratizzazione non ha dato i frutti sperati, povertà ed ingiustizia continuano a dilagare. Non c’è tunisino che si discosti da queste posizioni di scoramento e totale sfiducia nelle istituzioni e, soprattutto, nel futuro. Darsi fuoco è atto di ribellione estremo, ma non è un’azione collettiva, al contrario, ne è la negazione. È come se la rivoluzione continuasse, ma attraverso la distruzione dei singoli che l’hanno iniziata. Nelle ultime parole di chi è morto atrocemente tra le fiamme, c’è sempre un’accusa per qualche specifica mancanza dello stato, un qualche tipo di torto subito da parte del potere costituito. Nei racconti di chi è sopravvissuto, invece, ricorre la parola “hogra”, che indica la sensazione e la frustrazione di sentirsi invisibili, ignorati. Dopo il suicidio di Bouaziz, ci furono molte immolazioni con il fuoco. La matrice era quella dell’emulazione, e gli osservatori erano convinti che il fenomeno sarebbe durato qualche mese, come accade per tutte quelle azioni che, per qualche ragione, assumono una forza identitaria tale da convincere altre persone a intraprenderle a loro volta.
Ma gli esperti si sbagliavano.
Negli anni lo spirito emulativo è sparito, rimpiazzato ed alimentato dalla disperazione. L’immolazione con il fuoco è diventato il secondo metodo più usato per suicidarsi, triplicando le sue percentuali di scelta fra chi si era tolto la vita o aveva tentato di farlo. Solo con la pandemia la tendenza ha mostrato un rallentamento, ma le cifre sono rimaste sostanzialmente invariate, dimostrando che il fenomeno è solidamente installato nei costumi e nella cultura tunisina. I luoghi prescelti per darsi fuoco sono sempre gli stessi: commissari di polizia, uffici governatavi e, in generale, ogni luogo che rappresenta l’autorità o lo Stato. Ci si dà fuoco per un avviso di sfratto, per la luce o per il gas che vengono staccati, per un impiegato sprezzante, o per il rigetto di una pratica. Ad aprile, uno studente in lacrime per un qualche tipo di ingiustizia di cui si era sentito vittima, si è cosparso di benzina davanti ad un commissariato, brandendo un accendino. Per Issaoui, tutto è partito da una lite con un venditore di banane.
In un paese che aveva creduto di aver raggiunto libertà e democrazia, il futuro si è ridotto ad una scelta tra morire restando, o morire partendo. E così il cuore dei tunisini continua a bruciare di rabbia.
Fonti: Le Monde (Francia, articolo originale), tradotto e pubblicato in Italia da Internazionale (Italia); Wikipedia

